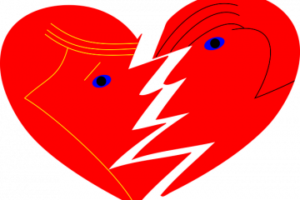L’irriducibile voce del cuore [di Basilio Scalas]
|
La mattina, di buon’ora, mi godevo il viaggio verso Cagliari, reso speciale dal fatto che a otto anni, lo facessi per la prima volta in macchina, nella millecento del dottore, perché l’automobile, come il televisore, era un lusso fuori portata per la nostra famiglia. Andare in città era cosa rara ed eccitante, i palazzoni di via Roma alti come il campanile, tanto vicini al mare che le navi sembravano in terra. Il via vai di gente, di carri, macchine e autobus con le antenne, i piccioni insolenti. Ma a colpirmi più di tutto erano le salite, che in certe strade sembrava di scalare una montagna, e al ritorno avrei potuto spiccare il volo, se solo mi fossi liberato dalla mano di mia madre. Quella mattina, niente salite e discese a piedi, arrivammo fino all’ingresso della clinica pediatrica come i signori, in macchina. La sera prima, come le altre, finita la cena in famiglia consumavamo le ultime chiacchiere attorno al braciere, prima di arrenderci al sonno. Nella quiete della penombra, il cuore cominciò a bussare forte, dal petto arrivò al cervello, fino a farmi male. L’aria si fecce ferro, la bocca aperta da un urlo senza suono, poi il nulla prese il posto delle persone e delle cose. Il fato volle che la faccia non finesse sui carboni ardenti. Il risveglio, tra mani e facce troppo vicine alla mia, il pianto disperato di mia madre che copriva gli altri suoni, fino all’arrivo del dottore, che tranquillizzò tutti, e mi rassicurò. Il sonno aiutato dai sedativi prese il posto del trambusto. In attesa di essere ricevuti dal primario, mentre i grandi confabulavano, seduto in un angolo dell’atrio, come per una illuminazione, riconobbi il luogo che da sempre era nella mia mente. Ero in braccio a mia madre, in un posto con molte vetrate, lei in affanno e confusa, non capiva da dove si potesse uscire. Io si, lo capivo, ma non parlavo. Poi finalmente si rivolse ad uno sconosciuto di passaggio che le indicò la direzione giusta, confermando quello che già sapevo, ma mi ostinavo a non rivelare. Fino a quel giorno, non mi è mai stata chiara l’origine di quei ricordi e se fossero tali, o se quelle immagini le avessero impresse i sogni. Nell’attesa che il primario ci ricevesse, chiesi a mia madre se fossimo già stati in quel posto, mi disse che avevo un anno e mezzo quando mi curarono una broncopolmonite. Incurante delle lacrime che quel ricordo aveva suscitato, mi godevo con segreta baldanza la certezza che quell’orma in memoria ce l’avesse lasciata l’infanzia. L’aria segaligna del professor Cao, si incupì fino a diventare truce man a mano che ascoltava il mio cuore. Con un ordine perentorio dispose il ricovero d’urgenza, che la madre superiora si incaricò di eseguire con la solerzia dei secondini. Tutto successe a una velocità tale che non ebbi neanche il tempo di avere paura. Alle lacrime di mia madre c’ero abituato e attorno c’erano un sacco di cose che dovevo imparare a conoscere. Nel pomeriggio mi fu recapitato il mio primo pigiamino, nuovo di zecca come le ciabattine, insieme ad alcuni rotoli di carta igienica, anch’essi una novità che andava a sostituire i più rassicuranti, per dimensione e consistenza, rettangoli di giornale normalmente usati. Mi adeguai in fretta alla vita da recluso, questa prevedeva che mi potessi alzare solo per i pasti e per i bisogni fisiologici, che dovessi recitare a voce alta le preghiere mattutine e serali e che, per nessun motivo, potevo oppormi alle tre punture giornaliere di penicillina, che non finivano mai di trafiggermi come un ferro rovente. Non avevo scampo a quella tortura, senza avrei corso un grande rischio, non so se per il cuore malato, o per mano della madre superiora. Agli adulti era consentito l’accesso due volte alla settimana, più la domenica, ai minori di quattordici anni, non era consentito l’accesso. Così per abbracciare mio padre dovevo aspettare la domenica, per mia sorella, avrei dovuto aspettare di tornare a casa. Preso atto che il cuore non funzionasse benissimo, mi sentivo abbastanza bene da considerare esagerate le preoccupazioni del professore, e col passare delle settimane anche le punture sembrarono meno dolorose. Scoprii per caso l’effetto che può produrre il borotalco su un pavimento liscio, dopo uno studio accurato dei passaggi del personale, riuscimmo a organizzare le gare clandestine di scivolata in lungo. Un giorno, il professore apparve in camerone, le nostre risate, in un niente, gelarono. Come le ossa, quando la superiora, reduce da una reprimenda che rimbombò per tutto il reparto, ci comunicò che eravamo i responsabili e della più grande umiliazione della sua vita. Io in particolare, non solo perché, con scarso cameratismo, fui indicato come ideatore del gioco, perché ero quello con la patologia più grave. Per la prima volta qualcuno, nella forma arcigna della superiora, mi parlò di morte, parlando di me. Cominciarono due settimane durissime di marcamento a bambino da parte della suora. Il peggio doveva ancora arrivare. Si trattava di un dubbio che mi portavo dietro dal primo giorno. Io conoscevo a memoria due preghiere, l’ave Maria e il Padre nostro, in ospedale si doveva recitare anche un’ode alla Madonna degli infermi. A fatica seguivo gli altri per il resto, ma su quella parola, con mille dubbi facevo di testa mia, si perché così come la dicevano tutti, per me era un inspiegabile errore collettivo. Imperterrito, dal momento che non conoscevo la parola infermi, recitavo la mia ode alla Madonna degli inferni. L’accusa di blasfemia mi cadde addosso come una condanna, dal momento che non ebbi il coraggio di confessare la mia ignoranza. Evitai l’incriminazione di satanismo per la giovane età, gli schiaffi di mia madre per via del cuore. Passarono due mesi e le cose cominciarono ad andare meglio, le cure sembravano funzionare e anche la superiora da qualche giorno aveva migliorato il suo atteggiamento, anzi lo aveva radicalmente cambiato. Le sue attenzioni si spinsero fino all’aggiunta di un dolcetto nascosto nel vassoio del rancio, oltre a qualche imbarazzata carezza. Dal momento che mi sentivo abbastanza bene, scartai l’ipotesi che una diagnosi segreta che prevedesse una mia imminente dipartita, avesse spinto a compassione l’aguzzina. Mia madre durante l’ultima visita indubbiamente era stata un po’ strana e parlava molto con la suora, ma questo non mi offriva una soluzione. Anche il bisogno di tornare a casa si era affievolito, così, quando dopo due mesi e mezzo di reclusione, di venerdì la superiora mi comunicò che la settimana successiva avrei potuto lasciare l’ospedale, la felicità esteriore superò di gran lunga quella interiore, ormai era il mondo esterno quello che sentivo estraneo, all’ospedale e il suo isolamento ci avevo fatto l’abitudine. Quella domenica mio padre, per la prima volta, venne da solo a trovarmi, disse che mamma era dovuta andare nell’ospedale lì vicino a trovare il fratello, zio Natale, che aveva avuto un problema al cuore. Volevo molto bene a zio Natale, ma non diedi troppo peso alla notizia, confortato dall’esperienza, sapevo che il cuore guarisce, come stava succedendo a me. La superiora irruppe nella camera trattenendo a stento l’affanno e le lacrime, mi chiese se quel signore al mio fianco fosse un parente e quando risposi che era mio padre, per un momento temetti per la sua e per la mia vita. Tuo padre è morto! Sentenzio confusa e corse via urlando qualcosa contro mia madre. Mio padre mi abbraccio per proteggermi dalla confusione attorno, senza riuscire a trattenere i singhiozzi. Zio Natale è morto, volevamo dirtelo quando saresti tornato a casa. Le lacrime presero il posto di tutto, per il dolore e per la voragine di insicurezza che quella notizia mi lasciava. Sentivo che la parola guarito, fino ad allora definitiva, diventava provvisoria e fragile. Lasciai l’ospedale con le raccomandazioni del professore e il saluto affettuoso della superiora, forse, convinta come me che per destino, la mia vita non sarebbe stata più lunga dei quarant’anni di zio Natale. Nel grande atrio, mia madre ebbe un’incertezza, la presi per mano e le dissi, vieni, lo so io. E al passo lento dei malati di cuore, la guidai verso l’uscita. |